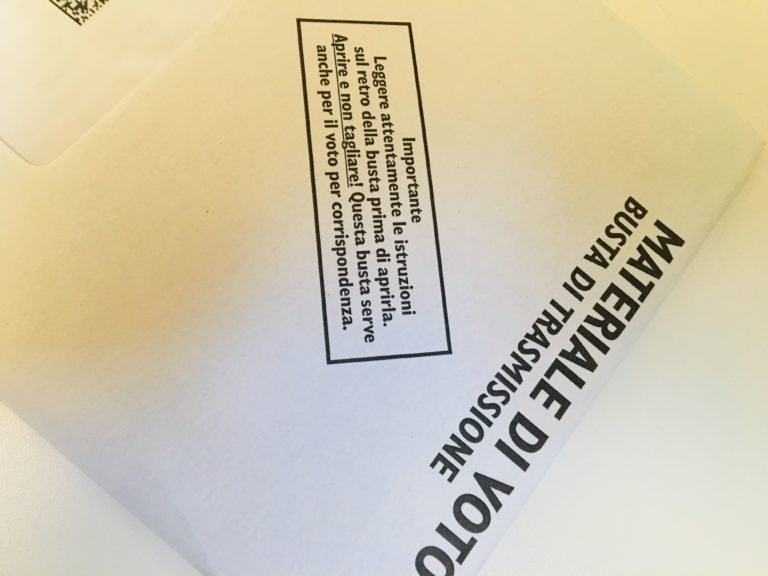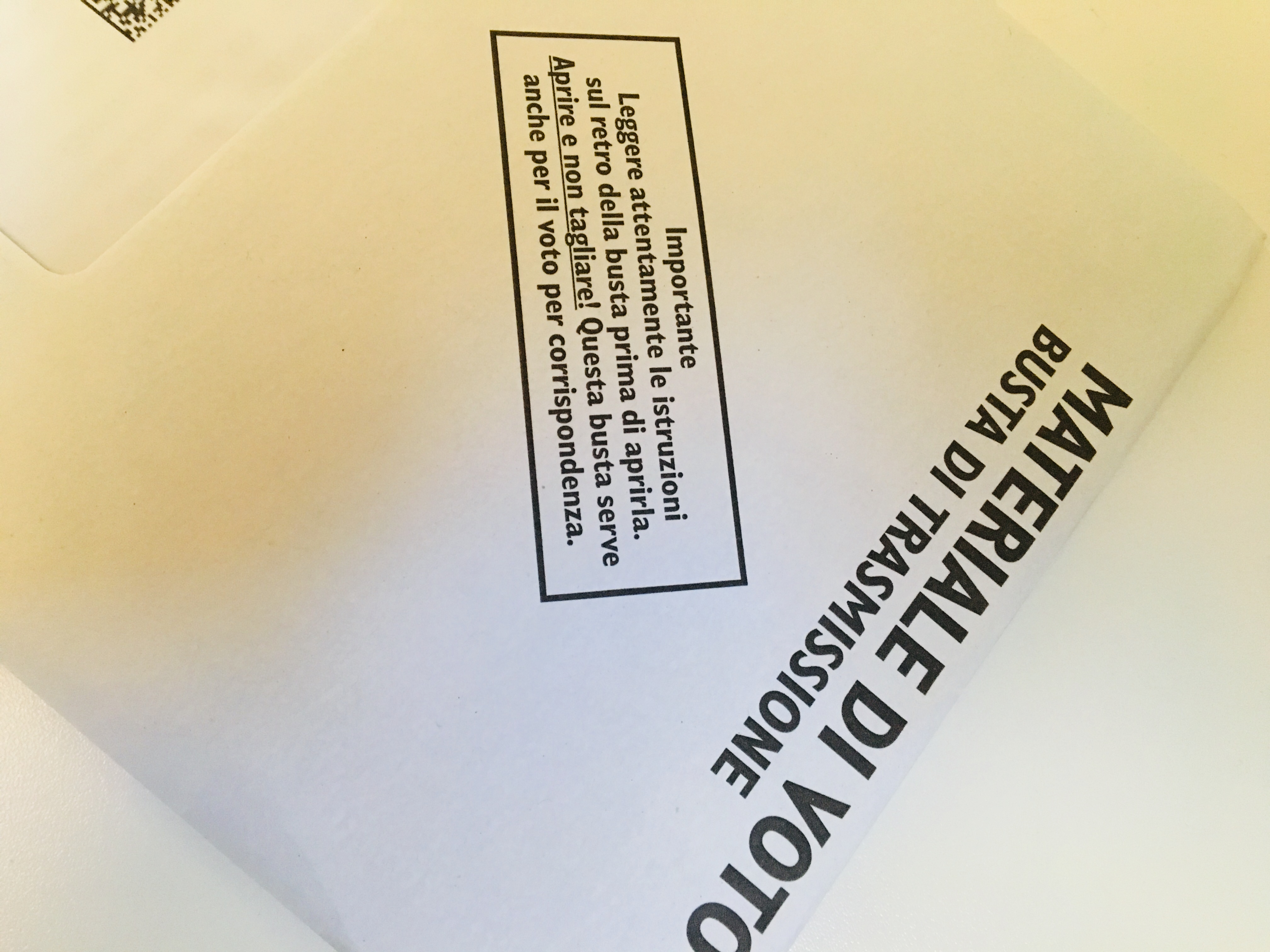Mi sono a lungo chiesto come fare a riassumere umori, pensieri, riflessioni, frustrazioni e timori degli ultimi mesi in poche righe. Sono settimane che vorrei scriverle, forse solo per me, per non arrivare a domenica prossima 4 marzo senza averlo fatto. Ma sono settimane che tergiverso: mi dedico sia per strada che in rete ai singoli temi sollevati dall’iniziativa, rispondo e cerco di promuovere certe riflessioni, mi attivo per quel poco che posso su alcuni fronti ma non riesco a riassumere tutto in qualcosa di personale che rimanga lì in una paginetta o meno.
L’iniziativa NoBillag mi ha permesso, o forse mi ha costretto, di vedere con occhi nuovi al mio Paese, la Svizzera. Benché non sia un dipendente della RSI e formalmente non lo sia mai stato, a 15 anni ho iniziato lì un percorso professionale e di vita fatto di collaborazioni, scambi, incontri e scontri con l’ente radiotelevisivo nazionale; sì, con la RSI e più in generale la SRG SSR. Se vado più indietro poi, posso dire che il mio rapporto con il Servizio Pubblico RadioTV ha quasi la mia età e non perché abbia un parente “in azienda” ma perché da quando ho memoria ho ricordi legati in qualche modo alle produzioni della regione in cui sono cresciuto.
Il 4 marzo compirò 36 anni e posso dire quindi di averli passati anche in compagnia del Servizio Pubblico. E per questo lo ringrazio. Per l’amor del cielo, la RSI non è stata LA mia vita, ma parte di essa di sicuro. C’è stato e continua ad esserci tanto altro. E quella di rimanere indipendente è stata una mia scelta e sono contento di poter fare una mia strada. Ciò non toglie che, qualunque cosa accadrà domenica prossima, la ringrazio. Con un po’ di nostalgia e un po’ di coraggio, perché quel che abbiamo vissuto negli ultimi mesi lascia una cicatrice. Io, che da quando son bimbo vado orgoglioso delle mie di cicatrici, so che si può uscire più forti da certi sberloni, ma dopo aver lasciato il tempo necessario perché se ne guarisse. Come con un famigliare o gli amici delle elementari, la RSI l’ho amata e criticata, mi sono piaciute alcune sue caratteristiche e altre no, mi ha accompagnato in tanti momenti mentre in altri ho voluto proseguire da solo perché un po’ annoiato della sua presenza. Come tutto ciò che ci è molto vicino fin da subito, ha contribuito alla mia crescita, nel bene e nel male, ed è parte in causa di ciò che sono ora. Non so se sia stato un aspetto positivo che io perdessi qualche ora della mia adolescenza guardando le puntate di MacGyver, ricordo però con grande piacere quando con la mia classe di quinta elementare partecipammo (e vincemmo) a Big Box, con “il Seve” che a quei tempi più che performance sportive commentava i giochi di noi bambini in diretta tv.
Quando a 15 anni, dopo aver tanto insistito, nella pausa estiva fra la prima e la seconda liceo, a Besso quelli di Rete Tre mi misero un microfono e un Revox (una macchina per montare le bobine audio) fra le mani ancora non lo sapevo che stavo muovendo il primo passo verso ciò che oggi è la mia vita. Non posso sapere quanto il pubblico radiofonico abbia apprezzato questa lunga e scoordinata presenza: probabilmente c’è chi ha amato certi programmi, altri meno. Ma sapere che ancora oggi va in onda BandZonAir mi rende un poco orgoglioso. E così, per me, poter andare e raccontare il Palèo Festival, il Montreux, il Festival di Locarno, poter fare lo staggista con Paolo, FAT! con Chià e Yari, Metropolis con una ciurma sempre diversa e operosa, parlare di vecchio cinema con Ale, mettere dischi nel cuore della notte e condividere così la mia grande passione per la musica, è stato un privilegio, un onore, un piacere e uno splendido lavoro. Ho passato ore e ore a far montaggi e tradurre interviste, non ero mai contento dei livelli e della sonorizzazione benché sapessi che a casa la maggior parte degli ascoltatori aveva una piccola radio mono accanto all’aspiratore in cucina. E così anche oggi, dopo qualche anno, passo le ore a mettere a posto un paio di suoni nel montaggio di un documentario per Storie con lo stesso spirito, conscio che in tanti quel documentario lo guarderanno sul loro tablet comodamente sotto le coperte magari con il volume al minimo per non svegliare i vicini. Tante avventure che mi hanno permesso di conoscere centinaia di persone, dentro e fuori la RSI, colleghi, tecnici, professionisti, interlocutori, ascoltatori, spettatori; avventure che oggi mi contraddistinguono in ciò che sono in positivo e nei miei tanti difetti. Tante avventure che se fossi nato già solo ad Andermatt o a Monza forse non avrei mai fatto. Forse, non posso saperlo. Avventure che potrebbero essere state migliori o peggiori, avventure per, con, da e in contrasto con un’azienda che è perfettibile, si mostra sì con alcune rughe e un po’ di ciccetta, ma che di sogni, storie, emozioni, passato presente e futuro ne racconta tante ogni giorno.
Benché questo attacco a qualcosa di vicino alla nostra identità e formazione, non solo la mia (e di questo ne sono certo), faccia male, a domenica arriverò con una nuova dose di coscienza e fiducia; arriverò conscio del fatto che esiste una Società Civile composta di persone che conoscono la differenza fra un bene nostro perché comune e un bene nostro perché individuale. E l’ho percepito in chi si è adoperato anche solo nel pensiero nella campagna per il NO a titolo volontario, con creatività e tempo perché solido in questo valore. Una Società Civile che forse ha dovuto prendere una cantonata per risvegliarsi e metterci la faccia, che forse si è rimboccata le maniche troppo tardi, ma che c’è e che se non smetterà di promuovere il bello, il pensiero, l’intelletto e le emozioni sane, condivise, potrà far tornare un poco di fiducia in tanti, troppi, che purtroppo – e qui sta la colpa di chi ha marciato in questo senso ma anche di chi non ha saputo difenderla – hanno perso la fiducia e cercano di sopravvivere convinti che non sia rimasto qualche sogno a cui ambire.
Lo spero, me lo auguro, per il mio prossimo giro di boa, il 4 marzo. Per tutti, anche per chi verrà e spero potrà vivere quel che ho vissuto io.
ps.: vien male perché vorrei citare tante persone, tanti luoghi, ricordi e in poche righe è dura. So che non si offende nessuno, ho preso un mazzo di ricordi fra gli innumerevoli a disposizione.
pps.: nella foto, il bambo con Badly Drawn Boy al Palèo Festival 2003.